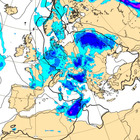La deposizione di Giorgio Napolitano al Colle «è inutile, dannosa per l’accertamento della verità». Questo giudizio non appartiene a un detrattore del processo sulla trattativa Stato-mafia, bensì ad Antonio Ingroia, il pm che il processo lo ha istruito. Per paradosso, stavolta si può essere totalmente d’accordo con Ingroia: l’udienza di ieri al Colle è stata inutile e dannosa, dato che il suo unico effetto concreto è aver permesso all’avvocato di Totò Riina di fare passerella al Quirinale e ipotizzare scenari revisionisti sulla storia d’Italia a uso e consumo del suo cliente. Naturalmente, la tesi di Ingroia è un’altra: la deposizione è inutile - così ha scritto in un lungo articolo uscito qualche giorno fa - perché sarebbero venute meno tutte le condizioni per arrivare all’accertamento dei fatti e perché non ci sarebbe la possibilità tecnica di rivolgere le giuste domande al capo dello Stato. In sostanza, in un colpo solo Ingroia ha messo le mani avanti sull’esito della deposizione, addebitando il suo più che probabile flop al lavorìo di non meglio precisati poteri forti, e sul processo tutto, offrendo la chiave di lettura che più compiace e convince i fautori di questo can can mediatico-politico.
E cioè: se dalla testimonianza di Napolitano non esce nulla non è perché nulla poteva uscirne. Al contrario, il nulla è la prova del tutto, l’evidenza che si lavora a coprire la verità. Se vi sembra assurdo che un pm, per quanto ex, ragioni con questa logica, andate a leggere cosa scrive Ingroia quando spiega quali domande avrebbe posto lui a Napolitano. Una di queste è: se il contenuto delle telefonate con l’indagato Nicola Mancino erano penalmente irrilevanti, perché Napolitano non ha fatto di tutto per renderle note e «sgombrare il campo da malignità e dietrologie»? A questo siamo: se le intercettazioni contengono notizie di reato vanno pubblicate, se non le contengono, pure. Dunque un cittadino - capo dello Stato o no - che si oppone a rendere pubbliche le sue telefonate ha qualcosa da nascondere. Una cultura del diritto raffinatissima, non c’è che dire.
In questo senso, l’aver portato il circo giudiziario al Colle ha comunque prodotto un risultato, inservibile in tribunale ma utilissimo sui media amici: si è coinvolta la prima carica dello Stato e si è gettato un seme velenoso per rafforzare, in quella parte di opinione pubblica che altro non aspetta, la convinzione che - se il Grande Processo si arenerà - non sarà per la sua inconsistenza ma a causa del muro di gomma del Palazzo.
Ci sono stati pezzi dello Stato che hanno trattato con Cosa nostra? Possibile. Ma bisognerebbe che questi pezzi fossero chiamati a rispondere davanti a ipotesi di reato chiare - non essendo ancora il reato di trattativa compreso nel codice penale - e che queste ipotesi fossero suffragate da prove. Invece la sceneggiatura del film Stato-mafia è stata redatta sulle dichiarazioni e sulle carte - il famigerato papello - fornite da Massimo Ciancimino, figlio dell’ex sindaco democristiano di Palermo colluso con la mafia e surrealmente divenuto idolo di un pezzo dell’antimafia militante. Dacché Ciancimino jr è diventato il teste chiave del processo sulla trattativa è stato arrestato e indagato in altre due vicende, per una delle quali è stato appena rinviato a giudizio dalla procura di Caltanissetta con l’accusa di calunnia aggravata, per aver prodotto falsi documenti e testimonianze allo scopo di screditare l’ex capo della polizia Gianni De Gennaro. Ma diamo per buona la presunzione d’innocenza, sorvolando sui guai di questo personaggio che per anni, nei talk impegnati, è stato intervistato con il riguardo che si deve ai martiri dell’antimafia. Resta che: l’autenticità del papello, a differenza di quanto scrivono i cantori ingroiani, è tutt’altro che dimostrata, anzi nelle motivazioni della sentenza di assoluzione del generale Mori, in un altro processo molto controverso chiuso con l’assoluzione dell’imputato, i giudici attribuiscono a Ciancimino «buona predisposizione a fabbricare documenti falsi».
Le rogatorie internazionali hanno smentito Ciancimino sul luogo di custodia del papello, che il collaboratore sosteneva essere - in una delle plurime versione fornite - all’interno di una cassetta di sicurezza in Liechtenstein. I giudici della IV sezione penale di Palermo scrivono che il presunto contropapello - che secondo Ciancimino fu redatto dal padre per addolcire le richieste iniziali di Cosa nostra - è un testo incongruo e inattendibile nella datazione. Non parliamo poi del fantomatico «signor Franco», l’agente dei servizi che avrebbe fatto da tramite con la mafia e al quale Ciancimino ha attribuito svariate identità - compreso lo stesso De Gennaro - facendolo apparire e scomparire dalla scena, con un ruolo diverso a ogni nuova testimonianza, e spacciando come provenienti dall’archivio del padre documenti risultati patacche. Alla fine il «signor Franco» sarebbe stato identificato in un placido barista romano. E si potrebbe andare avanti a lungo, non trascurando nemmeno le dichiarazioni di altri pentiti, tra cui il primo ad avere parlato della trattativa, Giovanni Brusca, secondo il quale il primo punto delle richieste mafiose era la richiesta di abolizione dell’ergastolo, che nei 12 punti del papello presentato da Ciancimino non c’è.
Le indagini sulla trattativa hanno smosso titoli e attenzione su scala internazionale, ma su queste basi era inevitabile che le udienze del processo che ne è scaturito si rivelassero degne di tanto trailer. In un documentato articolo sul dell’agosto scorso Massimo Bordin ha restituito una cronaca disarmante delle udienze svolte prima della pausa estiva, lontane dal clamore mediatico: pasticci, contraddizioni, tanta fuffa, pochissima sostanza. Basti raccontare un episodio: uno dei pentiti chiamati a testimoniare dall’accusa ha prima datato il golpe Borghese al 1980 e poi, davanti all’obiezione che il tentato golpe era del 1970, ha spiegato: «Ci volevano riprovare». Borghese, nel frattempo, era morto nel 1974.
Da tempo il presunto ruolo di Napolitano in questa vicenda è diventato la cortina fumogena dietro la quale nascondere l’implosione del dossier giudiziario. Nella deposizione al Colle lo scandalo non è la presenza dei legali dei mafiosi, che hanno diritto alla difesa in tutte le fasi. Il problema è l’impianto stesso dell’accusa, la costruzione di un teorema con forti accenti dietrologici - vedremo cosa ne resterà in sentenza - dove la volontà di accertamento dei reati passa in secondo piano rispetto all’intenzione di riscrivere la verità storica del Paese, compito che dovrebbe pertenere agli storici però, non ai giudici. «Un’inchiesta giudiziaria consente di rischiarare la storia politica con mezzi coercitivi di cui gli storici non dispongono», ha detto il procuratore aggiunto di Palermo Vittorio Teresi, che ha ereditato da Ingroia l’accusa, svelando con parole definitive quali sono i presupposti su cui fonda l’esercizio dell’azione penale in questo dibattimento.
L'inchiesta a rischio flop cerca diversivi
di Stefano Cappellini
Mercoledì 29 Ottobre 2014, 00:19
- Ultimo agg. 00:48
5 Minuti di Lettura